MANGIOCANDO
cibo, cultura, età della vita
28 maggio 2015
Leonardo Lenzi
Fame dell’Altro, fame dell’Oltre
Nutrirsi come questione antropologica e teologica
Vorrei iniziare
il mio intervento con qualcosa che forse potrebbe risultare disturbante. Ciò
che dirò ha a che fare con la fame,
una parola che in questa parte del mondo giunge addomesticata, tranquilla. Come
nota lo scrittore argentino Martìn Caparròs (Caparròs
M, La fame, Einaudi 2015), in questa
parte del pianeta abbiamo fame due o tre volte al giorno e, quando la avvertiamo,
la salutiamo allegramente, non essendo per niente difficile tacitarla: anzi, è
piacevole, è divertente farlo.
Salvo rarissime eccezioni siamo tutti nelle condizioni della
giallovestita signora della pubblicità dei cioccolatini, madre di tutti i doppi
sensi pubblicitari: non è proprio fame, è
un languorino, una voglia di qualcosa di buono, e con maggiore o minore
prontezza c’è sempre un Ambrogio a offrirci la possibilità della soddisfazione
di questa voglia. Attraversando Milano in questi giorni di Expo non si è quasi
in tempo di provarlo, il languorino, tanto il cibo in ogni forma è
onnipresente, ed entra anche dagli occhi sotto forma di immagini, di suoni. Si
rischia di fare indigestione anche solo passeggiando per la città. Non solo:
basta aprire Facebook per vedere centinaia di prelibatezze fotografate, perché
ormai il cibo prima di mangiarlo si fotografa e si condivide. Si condivide: ma in foto.
Ma –scrive Caparròs – tra la
fame ripetuta, quotidiana, saziata ripetutamente e quotidianamente che viviamo
noi, e la fame (“el hambre”) disperante
di chi non può soddisfarla, c’è tutto un mondo. Non è che non sappiamo che ogni giorno, ogni giro
del pianeta sul proprio asse, ogni 24 ore oltre 25000 persone muoiono per
ragioni connesse alla fame. Tragicamente e brutalmente Caparròs si chiede: ¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que
pasan estas cosas?
Possiamo: perché una cosa è sapere,
un’altra è realizzare, come mi ha
insegnato il mio maestro, Luigi Lombardi Vallauri. La differenza tra nozione e
realizzazione sta nel fatto che ciò che realizziamo ci coinvolge
esistenzialmente, ci fa trasalire: Oddio,
le cose stanno proprio così! Per esempio noi sappiamo che moriremo ma,
magari solo una volta nella vita, con una palpitazione dell’anima realizziamo
che veramente moriremo. E’ stato
detto che in principio era il pasto.
Forse. In principio c’è anche il fuoco, c’è la morte (e il culto dei morti). Ma
direi che in principio era l’angoscia,
e quel fortissimo dolcissimo nostro nonno appena affrancatosi dai primati, con
la stazione incertamente eretta e il pollice che si opponeva abbastanza, quel
nonno per cui io prego ogni sera, quel vero
Adamo che ha guardato le stelle e con una strana sensazione allo stomaco (
! ) scopre di essere soggetto separato dal mondo, e s’impaura. La prima, grande
realizzazione. Poi, magari fortunatamente, la realizzazione scompare e la morte
torna a essere semplicemente una nozione, anche piuttosto banale: Tutti gli uomini sono mortali, Leo è un
uomo, dunque Leo è mortale, ciò che gli studiosi di filosofia definirebbero
un sillogismo di prima figura in barbara, quanto di esistenzialmente più
innocuo si possa concepire. Per propiziare una realizzazione, cioè un sapere
intensivo e esistenzialmente coinvolgente, che faccia da sfondo a quanto sto
per dire, mi sono procurato un metronomo. Non essendo riuscito a trovare un
metronomo vero, ho scaricato un’applicazione per il mio smartphone. Ho
impostato il metronomo sul ritmo di 17 battute al minuto: ogni battuta
corrisponde a un essere umano, una donna, un uomo, una bimba, un bimbo, che in quel medesimo istante muore di fame.
Perché, se fate i conti, è proprio così: ogni minuto ne muoiono 17. Ecco, ora
lo attivo. […]
Mentre discutevo questa idea con altre persone, emergevano due diverse
possibili reazioni. La prima era il fastidio, la difficoltà o l’impossibilità di
seguire il contenuto di un discorso con questo sottofondo. La seconda era l’abitudine:
dopo un po’ potrei scoprire di non sentire più il ticchettio, il mio cervello
lo rimuove, lo annulla. Ebbene, queste sono esattamente le reazioni che
emergono quando si presenta alla nostra coscienza un contenuto impresentabile e
drammatico come el hambre: lo
rimuoviamo o ne siamo sopraffatti. Forse avrei potuto soltanto chiedervi di
chiudere gli occhi e fare consapevolezza per 45 minuti di questo larghetto di morte, osservando ciò che
vi accade dentro. Il mio spazio si sarebbe trasformato in una performance realizzativa. Ora, mi
sarebbe piaciuto, ma temo sia un’eccentricità alla John Cage che non posso
permettermi, o forse sono solo troppo poco self
confident per provarci. Nulla vieta però a voi di sperimentarlo a casa,
individualmente o in gruppo.
Abbiamo sempre mangiato: prima di parlare, prima di camminare, prima
di vedere. Da neonati il seno materno era dio. Non lo dico metaforicamente, ma
letteralmente: era dio. Morbido,
caldo, accogliente, e soprattutto nutriente. Era dio. Abbiamo vissuto in un
eden, e – come ben sanno i nostri mitici progenitori – dall’eden si viene
sfrattati presto (non a caso a causa dell’aver mangiato ciò che è vietato).
Così siamo stati svezzati, s-viziati. Questo percorso di individuazione
rispetto alla simbiosi edenico-alimentare con il seno materno è evidentemente
delicato e drammatico: il seno materno ritorna nei nostri sogni, talora nei
nostri incubi
Straordinario l’episodio del film di Woody Allen Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato
chiedere (1971) in cui lui viene inseguito da una gigantesca tetta
assassina che cerca di ucciderlo con spruzzi di latte, e davanti alla quale
brandisce – a mo’ di esorcismo – il crocefisso). Il seno materno e il desiderio
di ritornarvi e di abbandonarvisi ci sarà sempre: e fortunatamente Odisseo
forza i compagni a sottrarsi dagli incantati lotofagi, dimentichi di tutto,
perché rimanere renderebbe impossibile l’avventura umana. E un cherubino armato
di una spada fiammeggiante ci vieta il ritorno al giardino di Eden.
Nella narrazione biblica lo s-viziamento arriva dopo pochissime pagine
dall’inizio I progenitori potevano mangiare tutto eccetto del frutto del famoso
albero del bene e del male, ma fuori dall’Eden il rapporto col cibo diventa
complicato e sofferto, procurarselo significa estrarlo con dolore da un suolo maledetto.
Bisogna pur mangiare (Riva F,
Filosofia del cibo, Castelvecchi 2015).
Questo terribile dovere di procurarci il cibo, pena il cessare di esistere,
questa necessità di estrarlo con dolore dal seno ora maledetto della terra è di
una tragicità che raramente noi riusciamo a cogliere. Sono stato recentemente
in Russia, e – poiché mi ero perduto nell’immensa Mosca – ho chiesto
un’informazione stradale, trovando un signore che parlava inglese. Alla fine
l’ho ringraziato, ma lui mi ha detto molto gentilmente: Five bucks, please. I’m sorry, but I don’t eat ‘thankyous’. Cinque
dollari, o euro, non so: mi scusi, ma io non mangio “grazie”. Bisogna pur
mangiare.
Le filosofie e le religioni hanno da sempre e acutamente avvertito il
peso atroce di questa necessità, e hanno pensato, desiderato e sognato modi per
affrancarsene. Gli angeli non mangiano. C’è una brutalità spaventosa insita in
quest’atto universale. Tutta l’etichetta, il galateo, le buone maniere a
tavola, tutto ciò nasce come un tentativo fallito in partenza di renderlo
tollerabile. Non si tratta in prima battuta di una questione morale: certo, la gola viene condannata e stigmatizzata,
ma si capisce che il fondamento di questa resistenza è ben più profondo. E’ che
si percepiva l’orrore di questo ingerire, ingurgitare, masticare il mondo,
triturare, gettare nelle nostre interiora altre forme, altre vite, talora
senzienti.
Così Palomar, il protagonista osservatore malinconico di una serie di
racconti di Italo Calvino (Calvino I,
Palomar, Mondadori 1994), un giorno
entra in una macelleria:
Dietro il
banco, i macellai biancovestiti brandiscono le mannaie dalla lama trapezoidale,
i coltellacci per affettare e quelli per scorticare, le seghe per troncare gli
ossi, i batticarne con cui premono i serpeggianti riccioli rosa nell’imbuto
della macchina trituratrice. Dai ganci pendono corpi squartati a ricordarti che
ogni tuo boccone è parte di un essere alla cui completezza vivente è stato
arbitrariamente strappato
Senza assolutamente entrare nella questione molto complessa e delicata
(dal punto di vista etico e antropologico) relativa alla scelta fra alimentazione
carnivora o vegetariana, è per me sufficiente soffermarmi sulla forma perfetta,
integra, meravigliosa di una mela.
Se neppure una volta ci siamo soffermati con costernazione e anche con
un sentimento quasi di inevitabile colpa prima di addentare una mela forse non
potremo mai capire verso quale fondo oscuro, ferino e terribile ci possa
condurre una riflessione sulla fame e sul cibo. L’essere vive a spese
dell’essere in un ciclo di voracità che sembra non interrompersi mai. L’uomo è ciò che mangia e mangia ciò che è (er
ist was er ißt und ißt was er ist) (Riva
2015)
Se questo è vero, si può dire però che l’uomo è anche – soprattutto – ciò che ‘non’ mangia (Niola M, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, Bologna: Il
Mulino, 2015; Riva 2015). L’uomo,
è possibile sorprenderlo nell’atto dell’astenersi da certi cibi: si va dal tabu
transculturale del cannibalismo (di cui il nostro profondo mantiene tracce
evidenti: c’è chi dice che il bacio stesso, lungi dall’essere l’apostrofo rosa nell’espressione ‘T’amo’,
come dicono il Cyrano di Rostand e milioni di baci perugina, sia nient’altro
che la sublimazione di un originale cannibalismo; certo è che in alcuni sguardi
soprattutto di zie davanti a paffuti pargoletti io ho visto più appetito che affetto; non solo negli
sguardi, anche nelle parole: ti mangerei
di baci) alle astensioni religiose, alla ahimsa indiana ed rappresentata nel suo estremo nel giainismo, dove
gli asceti muoiono di inedia pur di
non commettere violenza alcuna, alla kasherut
ebraica, ai digiuni che fanno parte di ogni tradizione religiosa, inclusa
quella ebraica, cristiana e islamica, alle sante anoressie, religiose e anche
no (come l’anoressia sociopolitica di Simone Weil), alle diete contemporanee,
problematiche – come si vedrà – e con possibili derive patologiche.
L’uomo è ciò che mangia / L’uomo è ciò che non mangia. Ancora una
volta riflettere sul cibo rinnova la domanda che Israele si pone nel deserto,
quando – evaporata la rugiada – trova sul terreno una sostanza sconosciuta e
commestibile.
Man hu? Che cos’è? (Es 16, 16-18) : Quando i figli di Israele la videro si dissero l’un l’altro: ‘Che
cos’è’? perché non sapevano cosa fosse. E Mosè disse loro: ‘Questo è il pane
che l’Eterno vi ha dato da mangiare. Che cos’è il cibo, ma anche che cos’è
l’uomo, che di fronte al cibo si trova – come del resto di fronte a tutto –
perplesso, invischiato in un dilemma : cos’è il cibo, come devo prenderlo,
cosa sono io che lo mangio ? Infatti le prescrizioni alimentari relative
alla manna hanno a che fare sia con la concessione gratuita e celeste del cibo
(il pane che il Signore vi ha dato)
che con la limitazione della voracità: gli Israeliti non possono prenderne se
non in modo che non ne avanzi fino al mattino, altrimenti essa si riempie di
vermi e imputridisce. E’ inevitabile che perfino questo, perfino il pane che
ogni giorno miracolosamente Dio fa scendere nel deserto, non basti all’uomo.
Che infatti presto mormora, protesta. I
figli di Israele ripresero a piagnucolare e a dire: “Chi ci darà carne da
mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che in Egitto mangiavamo gratuitamente, dei
cetrioli, dei meloni, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ma ora l’intero
essere nostro è inaridito; davanti ai nostri occhi non c’è nient’altro che
questa manna (Num 11, 4b-6). La collera dell’Eterno divampa, schiacciando
ancora una volta Mosè nel suo tragico ruolo di mediatore tra un Dio permaloso e
collerico – che sembra ancora non aver preso
le misure rispetto alla natura umana – e un popolo, il suo popolo, incredulo
e di testa dura. E allora Dio dice: Volete mangiare carne? Frignate perché non
avete carne? Ebbene ne avrete, e non per un giorno, non per una settimana, io
vi darò così tanta carne che – letteralmente – vi uscirà dalle narici e vi verrà a noia. Ed è straordinario che a
questo punto perfino Mosè dubita di questo Dio smargiasso, e lo mette in
guardia: Questo popolo conta seicentomila adulti, la sua voracità è senza fine.
Si possono uccidere greggi e armenti in
modo che ne abbiano abbastanza? O si radunerà per loro tutto il pesce del mare
in modo che ne abbiano abbastanza? Mosè intende dire che non ne avranno mai abbastanza. Ma il Signore fa salire
un vento e getta sull’accampamento di Israele un’infinità di quaglie, tanto che
è scritto che chi ne prese di meno ne ebbe quaranta chili. Ma il Dio con cui
questa parte della Scrittura ha a che fare – lo abbiamo accennato – è un Dio
ancora giovane, bellicoso, passionale e feroce. E infatti: Avevano ancora la carne fra i denti e non l’avevano ancora masticata,
quando lo sdegno del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse
il popolo con una grandissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibrot-Taava
(sepolcri avidi), perché qui fu sepolta
la gente che si era lasciata dominare dall’ingordigia. Che significa? La
Bibbia è piena di queste stranezze, perché ad essere strano – come tante volte
dice il Professor Petrosino che interverrà questo pomeriggio – è l’uomo stesso.
Forse uno degli argomenti che provano l’origine divina della Scrittura è che
solo il Creatore dell’uomo può conoscerlo così bene nella sua
contraddittorietà. In questo caso sì, l’uomo ottiene quanto il suo godimento
desidera, ma questo stesso godimento non si può neppure realizzare, esso muore con la carne tra i denti non ancora
masticata.
L’uomo abita questa tensione, questa lacerazione tragica. E’ ciò che
mangia, e contemporaneamente ciò che non mangia, quindi non si sa bene cosa
sia. Ancora Palomar
Pur
riconoscendo nella carcassa di bue penzolante la persona del proprio fratello
squartato, nel taglio della lombata la ferita che mutila la propria carne, egli
sa di essere carnivoro, condizionato dalla sua tradizione alimentare a cogliere
da un negozio di macellaio la promessa della felicità gustativa, a immaginare
osservando queste trance rosseggianti le zebrature che la fiamma lascerà sulle
bistecche alla griglia e il piacere del dente nel recidere la fibra brunita.
Un sentimento
non esclude l’altro: lo stato d’animo di Palomar che fa la fila nella
macelleria è insieme di gioia trattenuta e di timore, di desiderio e di
rispetto, di preoccupazione egoistica e di compassione universale, lo stato
d’animo che forse altri esprimono nella preghiera.
Come si esce da questo dilemma? Occorre dire che filosofie e religioni
non aiutano. Se prescrivono il digiuno, dall’altra parte il banchetto – anche
sacrificale – è un modo, se non il
modo, per entrare in comunicazione col divino. La via ascetica è raccomandata,
ma sotto-sotto si capisce che c’è una via segreta, tantrica, prediletta, che
invece ha a che fare con gli eccessi anche più terribili.
Il buddhismo comprende tutto: dal mangiar nulla – o quasi nulla – al
mangiare il mondo, nutrirsi di tutto, di carne umana, di cadaveri, a
dimostrazione che un’elevata condizione spirituale si fa beffe delle regole e
divinamente le capovolge, fino ad usare lo stesso peccato come combustibile
energetico verso l’illuminazione. Anche il cristianesimo conosce queste
polarità, da una parte l’asceta digiunatore del deserto, o la mistica che si
nutre solo di eucarestia, e dall’altra il dichiarare tutti i cibi puri e creare
una vera cultura della buona tavola. In fondo questo risale alle origini. A chi paragonerò gli uomini di questa
generazione? E a chi somigliano? Sono simili ai fanciulli nelle piazze e
gridano gli uni agli altri, dicendo: ‘Noi vi abbiamo suonato il flauto e non
avete ballato, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto’. E’ venuto
infatti Giovanni Battista che non mangia pane né beve vino, e voi dite: ‘Egli
ha un demone’- E’ venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve, e voi dite:
‘Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori’. E
anche l’islam non è estraneo al dilemma: si pensi solo all’importanza del vino
e dell’ebbrezza (rigorosamente vietate) nella via pazza d’amore del derviscio.
Non che non ci siano santi e filosofi che raccomandino l’equilibrio, la
moderazione, il compromesso: ma c’è qualcosa che ce li fa sentire un po’
fasulli. Un po’ come quella comunità nordica e protestante che accoglie la
Babette di Karen Blixen, grande chef al Cafè Anglais fuggita da Parigi in
incognito, che per sdebitarsi investe tutto il denaro di una vincita per
preparare una cena incredibile a base di brodo di tarataruga, blinis Demidoff,
e le inimitabili quaglie en sarcophage,
quasi firma dell’artista. Il cibo sconvolge di piacere la vita moderata e
sensata, il gusto li esalta, il vino li inebria, fino a che uno di essi dirà
che in quella sera rettitudine e felicità
si sono baciate.
Ho preparato questo intervento in un dialogo costante con un’amica,
che è qui presente, la dottoressa Margherita Tassi. Margherita segue una
disciplina spirituale che prevede molte astensioni, in particolare dalla carne,
dall’alcool, dagli intossicanti. Contemporaneamente lei sente che è attraverso il corpo che è chiamata a incontrare il
mondo e i suoi bassifondi, i suoi dolori. Allora non può negare che ci sia una
contraddizione tra la logica immunitaria
– che presiede alla sua via spirituale – e la logica comunitaria – che guida il suo agire quotidiano.
E dilemma si aggiunge a dilemma.
La blogger Flavia Gasperetti (Gasperetti
F, “Una caponata ci seppellirà, ovvero come il food ha ucciso il cibo” in The
Brain that Drained, flaviagasperetti.wordpress.com) elenca in modo molto
divertente i teneri dubbi del foodie.
La ricotta confezionata alla meglio da un vecchio pecoraio avvinazzato sotto la
tangenziale o il ristorante tristellato? Il foie
gras – che certo non è animalista ma vuoi mettere la grande tradizione che
c’è dietro – o la cucina vegana e nonviolenta? Il kilometro zero o il commercio
equo e solidale? La filiera trasparente o la conserva prodotta da mani mai
sfiorate da un controllo qualità? Il Bio a tutti i costi o gli OGM che forse
salverebbero dalla morte intere popolazioni?
E dilemma si aggiunge ancora a dilemma. Perché è giusto pensare a nutrirsi
‘bene’, a nutrirsi in modo ‘sano’. E’ giusto difendersi dall’obesità e dagli
svantaggi clinici e sociali che da essa derivano. E’ giusto mettere in atto le
cosiddette tecnologie del Sé (Niola 2015), tutte le competenze,
esperienze, conoscenze, comportamenti tesi a prendersi cura del proprio corpo e
che ci rendono sempre più sani, belli, attivi, giovani, longevi, potenzialmente
immortale. E’ giusto dichiarare guerra ai radicali liberi. E’ giusto: anche se magari
nel prossimo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),sarà inclusa, come patologia
mentale, anche l’ortoressia (da orthos:
corretto e orexis: appetito), ossia
quell’ossessione per le regole alimentari, per la scelta dei cibi, per le loro
caratteristiche. L’eccesso di salute produce malattia.
Come giustamente sottolinea Niola, la nostra sta diventando una
alimentazione in levare. Senza uova,
senza latte, senza sale, senza zucchero, senza grassi, senza colesterolo, senza
carboidrati, senza lieviti. Hanno perfino agito sul sacro, facendo ostie gluten
free.
Hanno agito sull’arte,
facendone una versione gluten free (non so se ironicamente: lo spero)
Ci si chiede in siti ufficiali (celiacdisease.about.com) se un celiaco
o una celiaca possa baciare il partner se ha appena mangiato cibi contenenti
glutine, se ha bevuto una birra, se usa dentifricio o collutorio che contengono
glutine, se usa rossetti contenenti glutine. E – bontà sua – ricorda alle anime
innocenti (sic) che questo non vale per il bacio sulla guancia dato alla nonna.
Se qualcuno è interessato a sapere cosa fare, ebbene occorre che il
partner prima di baciarvi si lavi accuratamente il cavo orale con prodotti
gluten free e che i suoi cosmetici (vale anche per il make-up) siano gluten
free. Si raccomanda anche (giuro) di spazzolarsi accuratamente i baffi per
evitare che alcune microbriciole siano rimaste attaccate. How romantic! Siamo al delirio immunitario, e lo dico da celiaco.
Perché il nostro nemico non è più la fame, ma l’abbondanza, col suo
corteggio di sensi di colpa, di fobie, di allergie, di intolleranze.
La nostra vita
sta diventando una cucina “senza”. Una continua sottrazione alimentare.
L’opposto di quella dei nostri genitori, che era tutta un’addizione. La
differenza è che loro avevano fame di vita, mentre noi della vita abbiamo
paura. (Niola 2015)
Perché anche qualora tutto vada a posto con il nostro girovita, resta
il problema della nostra vita. Dove sta andando?
Ora che all’occhiuto triangolo divino si è sostituita la piramide
alimentare, ora che la nostra etica si trasforma in diet-etica (che non è
affatto una daiet etica, un’etica
leggera, anzi, è esigente, cupa, severa, spesso perfino tirannica), qual è lo
scopo della nostra vita. E’ veramente la longevità? E’ veramente il benessere? Non
ci viene il dubbio che l’uomo dia il meglio di sé proprio in un disequilibrio?
Che le scintille di senso si sprigionino proprio quando esso è schiantato da
Dio, dalla sorte, dal caso, insomma quando è spezzato sugli scogli appuntiti
dell’esistenza? Van Gogh riempiva la cavità oscura del suo stomaco con pessimo
liquore d’assenzio: e certo non osservava la dieta mediterranea. E’ morto a
trentasette anni. Eppure il suo sguardo trasfigurava in bellezza suprema i
cieli, i corvi, i campi di girasoli. Perché non è vero che prima di tutto viene la salute. Se volete fare un’esperienza
interessante – io l’ho fatta – andate a sedervi una sera, dopo le 18, su una
panchina della montagnetta di san Siro. Assisterete all’incredibile spettacolo
dei runners, cioè di quelli che
corrono, corrono, corrono. Vestono di colori smaglianti, fosforescenti, hanno
cuffiette con musica che favorisce l’allenamento e fasce elastiche per gli
smarthphone con l’applicazione che registra tutto, dal battito cardiaco alle
calorie consumate. Prevalentemente sono uomini e donne dai quarant’anni in poi.
I loro figli diciottenni – posto che non siano atleti semi-professionisti – non
ci vanno mica, a correre. Se ne stanno spetasciati
(come se non avessero ossa) sul divano a chattare su whatsapp e a ascoltare
spotify. Ma dopo i quarant’anni ecco che si comincia a pre-sentire la fine, la
morte. Allora si comincia a correre, perché la morte non ci prenda, e si
guardano i tempi, si confrontano con quelli fatti l’anno prima, perché la morte
è veloce e potrebbe raggiungerti. Un caro amico – che fa le maratone – mi
diceva che nell’ultima decina di kilometri della gara quello che senti è che
qualcosa, da dentro, ti sta mangiando. Che stai mangiando te stesso attraverso
la fatica.
Che cos’è questa nostra vita? La domanda sul cibo (man hu? che cos’è?) esplodendo in
innumerevoli domande che non possono avere risposta, ci ha ricondotto qui. Il
mio intervento vorrebbe essere come una premessa a quello che sperò dirà il
professor Petrosino, mostrandoci se e come è possibile rimanere umani dentro il collare tragico della fame e della
necessità di mangiare, ed esplorando il salto di senso – già proposto da
Emmanuel Levinas – tra bisogno e desiderio, ossia riconoscendo
nell’urlare del bisogno il levarsi di un desiderio perfino più grande, un
desiderio propriamente umano: cioè un desiderio infinito.
Quanto a me, vorrei tornare all’inizio, alla condizione terribile che
– in questo istante – stiamo vivendo. A pochi metri da noi la celebrazione del
cibo, del gusto, della vita, ma – nelle nostre orecchie – il ticchettare
lugubre che scandisce il larghetto
della morte per fame. Ascoltiamolo ancora per qualche secondo. […]












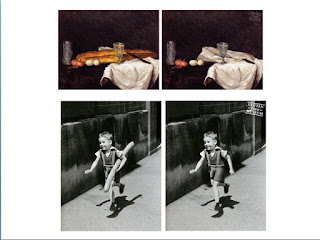




Nessun commento:
Posta un commento